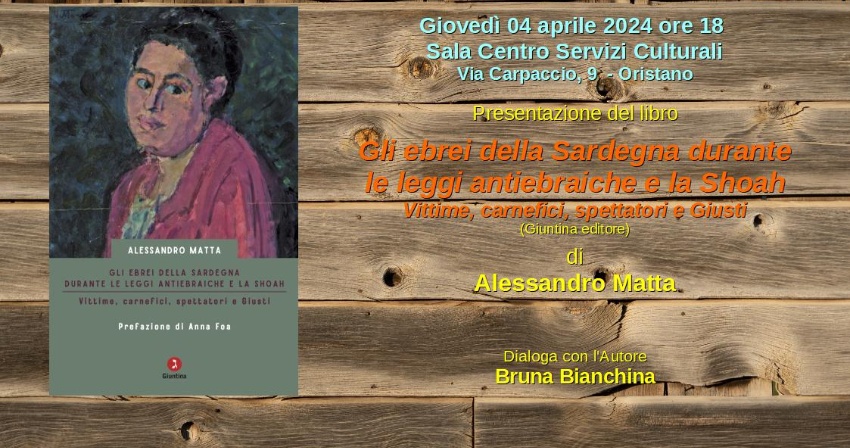La Sardegna, terra di antiche tradizioni e crocevia di culture, custodisce un legame millenario con il mondo ebraico, testimoniato da tracce linguistiche e usanze culinarie che si tramandano di generazione in generazione. Mario Carboni, in un’appassionata riflessione, ci guida alla scoperta di questo legame, partendo dalla lingua sarda, un idioma neolatino unico, studiato in tutto il mondo per le sue peculiarità.
Tracce Linguistiche ebraiche in Sardegna
Il mese di settembre, “Cabudanni” in sardo, richiama il “Rosh Hashanah” ebraico, l’inizio dell’anno. Il venerdì, “Chenàbura”, evoca la “Coena pura”, la vigilia di Pesach, la Pasqua ebraica. E ancora, “Lampadas”, giugno, ricorda le lampade accese nel solstizio d’estate.
Queste tracce linguistiche, secondo il linguista Max Leopoldo Wagner, sarebbero state introdotte in Sardegna dagli ebrei del Nord Africa, durante il periodo in cui l’isola era sotto il dominio dell’Esarcato d’Africa o di Cartagine.
“Su Pane Purile”: L’Azzimo Sardo, un’Eredità Culturale
Ma è nella tradizione culinaria che il legame tra Sardegna ed ebraismo si manifesta con maggiore evidenza. “Su Pane Purile”, o “Cotzula Purile”, è il pane azzimo sardo, preparato senza lievito e consumato durante la Pasqua ebraica, il Pesach.
L’assonanza tra “Purile” e “Purim”, la festa ebraica che precede Pesach, testimonia l’influenza della cultura ebraica nella tradizione sarda.
Un’Usanza Antica, un Legame Vivo
La preparazione del “Pane Purile”, descritta da viaggiatori e scrittori come Padre Antonio Bresciani, rievoca le usanze bibliche, con la cottura del pane nella cenere calda o sui carboni.
Un’usanza che si è tramandata nel tempo, fino ai giorni nostri, quando alcune confraternite neocatecumenali cattoliche celebrano l’Eucaristia con pane azzimo, rievocando l’Ultima Cena di Gesù, ebreo praticante, che consumò pane azzimo durante il Seder pasquale.
Mario Carboni, con i suoi ricordi d’infanzia, ci riporta alle tradizioni familiari, quando “Su Pane Purile” veniva preparato con cura e passione, un gesto che univa le generazioni e custodiva un’eredità culturale millenaria.
 English
English French
French German
German Italian
Italian